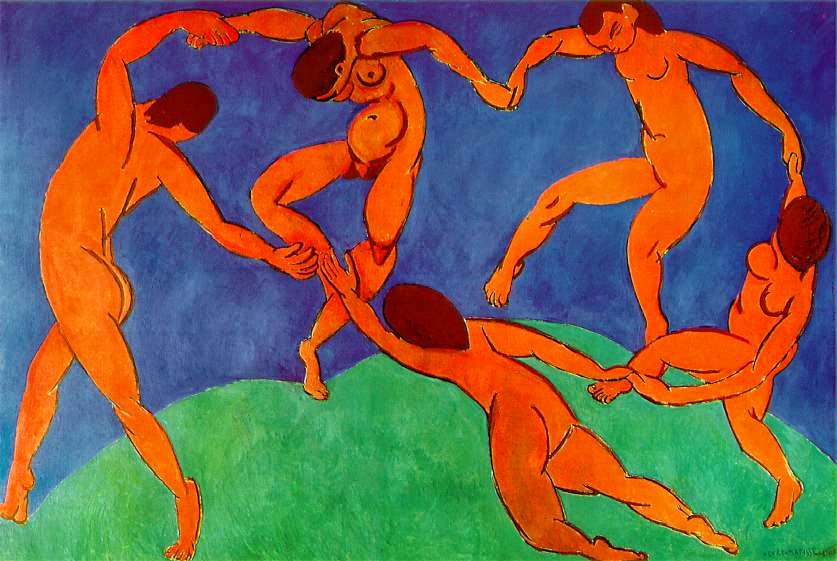Ci sarebbero centinaia di motivi per i quali pensare che una guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord sia impossibile dal verificarsi, eppure questi potrebbero non bastare. Le cronache internazionali recenti sono sempre più contraddistinte dalle notizie di esperimenti nucleari nordcoreani e dalle conseguenti reazioni statunitensi. La situazione di tensione tra i due paesi, di lunga durata ma finora latente, si è intensificata con la salita al potere di Kim Jong-un nel 2011 e recentemente con l’elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, che pure si era detto disponibile a dialogare con il regime di Pyongyang. La presenza ai vertici di questi due paesi di personalità forti ed imprevedibili rende ancora più pericoloso il confronto.
Ci sarebbero centinaia di motivi per i quali pensare che una guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord sia impossibile dal verificarsi, eppure questi potrebbero non bastare. Le cronache internazionali recenti sono sempre più contraddistinte dalle notizie di esperimenti nucleari nordcoreani e dalle conseguenti reazioni statunitensi. La situazione di tensione tra i due paesi, di lunga durata ma finora latente, si è intensificata con la salita al potere di Kim Jong-un nel 2011 e recentemente con l’elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, che pure si era detto disponibile a dialogare con il regime di Pyongyang. La presenza ai vertici di questi due paesi di personalità forti ed imprevedibili rende ancora più pericoloso il confronto.
Il dato preoccupante è che un conflitto tra Stati Uniti e Corea del Nord comporterebbe uno scontro dalla portata globale, una nuova guerra mondiale, con scenari imponderabili e mutevoli, e che potrebbe riproporre una contrapposizione a blocchi che credevamo di aver superato dopo la caduta del muro di Berlino: da una parte uno schieramento occidentale a guida Usa e dall’altra uno schieramento post-comunista, con la Cina e Russia, rivali degli Stati Uniti ma non certamente alleati di Pyongyang, che a vario titolo e grado potrebbero far parte della contesa. Senza dimenticare che una guerra mondiale al giorno d’oggi significherebbe una guerra nucleare, con conseguenze devastanti per l’intera umanità. L’incubo di un “generale Ripper”, il folle personaggio del film “Il dottor Stranamore” di Stanley Kubrick che per via delle sue paranoie causa l’apocalisse, torna a vivere. Può la logica della deterrenza, che ha funzionato durante la Guerra Fredda, funzionare anche ora?
Per rispondere a questo quesito bisognerebbe indagare sulla razionalità degli attori. In una situazione di distruzione mutua assicurata (in inglese mutual assured destruction, MAD), in cui tutte le parti posseggono armi nucleari e perciò finirebbero per annientarsi l’un l’altra, nessuno si sognerebbe di eseguire l’attacco. Questo clima ha caratterizzato il periodo detto di “equilibrio del terrore” durante la guerra fredda che ha fondamentalmente tenuto in piedi il mondo, seppur sul ciglio di un burrone. Stati Uniti ed Unione Sovietica erano potenze che non solo capivano e ricercavano la deterrenza, ma sapevano anche farla funzionare: numerose erano infatti le occasioni di dialogo per darsi regole e porre limiti. I due attori della Guerra Fredda erano perciò totalmente razionali.
Su Kim Jong-un le opinioni sono ancora discordanti. Le storie che lo riguardano, riportate sui media occidentali, non ne tratteggiano un personaggio ragionevole e coscienzioso. È tuttavia da confermare la veridicità di tali storie, le quali potrebbero invece essere state confezionate per alimentare un certo tipo di narrazione ad uso e consumo occidentale. Quel che di certo si sa riguardo a Kim Jong-un, è che si tratta di un leader risoluto e spietato, che ha concentrato e consolidato nelle sue mani un potere che prima non aveva. Potrebbe essere capace di tutto, ma esperti non ne negano la razionalità. Kim Jong-un non sarebbe dunque soltanto un pazzo. Di Trump invece che cosa potremmo dire?
La politica di Trump nei riguardi della Corea del Nord è meno indulgente rispetto a quella di Obama, che invece puntava sulla “pazienza strategica“, ovvero l’attesa di una crisi interna al regime di Pyongyang che ne avesse sancito la fine. L’aggressività e l’escandescenza di Trump nei confronti della Corea del Nord e del suo leader, già manifestata prima ancora della sua elezione, potrebbe aver influito sul comportamento del regime che con l’acquisizione dell’arma nucleare non cercherebbe altro che un motivo di esistere di fronte alla comunità internazionale.
Trump e Kim, i due ossi duri della politica mondiale, si ritrovano quasi per caso protagonisti di un gioco di brinkmanship dove a rischiare ancora una volta non sono solo le due parti in gioco, ma è il mondo intero, come nella Guerra Fredda. Una situazione che da apparentemente innocua e gestibile diviene incontrollabile, proprio come nel film di Kubrick. Speriamo solo non finisca allo stesso modo.